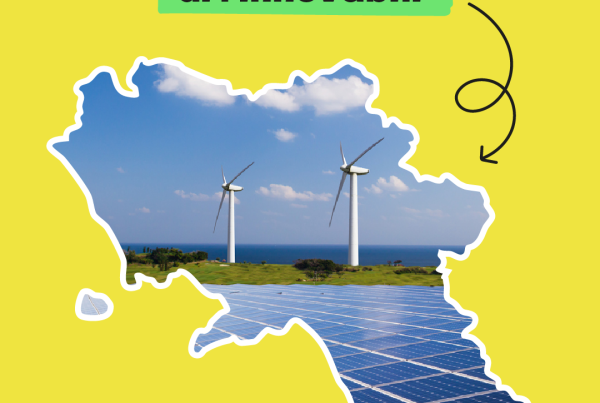Un viaggio attraverso il tempo: l’energia dell’acqua dall’antichità al futuro digitale
L’impeto dell’acqua, forza primordiale e indomabile, ha da sempre affascinato l’umanità. Fin dai tempi antichi, Greci e Romani, con ingegno pionieristico, imbrigliavano la sua energia per azionare i mulini, precursori meccanici di un futuro energetico. L’eco di questa scoperta risuonò attraverso i secoli, raggiungendo il Medioevo, dove gli Arabi, con la ruota idraulica, trasformarono deserti in oasi, irrigando campi e prosciugando paludi.
Un salto repentino nel tempo ci porta alla fine dell’Ottocento, un’epoca di fervore industriale e innovazione tecnologica. L’Europa, culla del progresso, vede la nascita delle turbine motrici, mentre nel 1878, nella quiete campestre di Cragside, in Inghilterra, una singola lampada si accende, alimentata dalla forza di un fiume: il primo barlume di un’era nuova. Pochi anni dopo, nel 1880, il Wisconsin, cuore pulsante dell’America, inaugura la prima vera centrale idroelettrica, seguita a ruota da altre installazioni a Grand Rapids, Ottawa e Dolgeville, che illuminano le notti e alimentano le industrie locali.
Le maestose cascate del Niagara, simbolo di potenza naturale, diventano anch’esse protagoniste di questa rivoluzione energetica. Nel 1881, la loro energia viene imbrigliata per illuminare la notte, creando uno spettacolo di luce e acqua che anticipa le meraviglie del futuro.
L’Italia, terra di sole e acqua, non rimane indietro. All’inizio del Novecento, l’idroelettrico si afferma come la principale fonte energetica del paese, guidata da visionari come Aldobrando Netti, pioniere della corrente alternata, che realizza la prima centrale idroelettrica a Narni.
Oggi, l’Italia conta quasi 5.000 centrali idroelettriche, concentrate principalmente nel Nord, testimonianza di un percorso lungo e complesso. L’idroelettrico non è solo una fonte di energia pulita, ma un alleato prezioso per la stabilità della rete elettrica, la prevenzione delle inondazioni e la salute dei corsi d’acqua. Un’energia economica e sostenibile, resa ancora più efficiente dalla digitalizzazione, nonostante gli elevati investimenti iniziali.
Ma come funziona? Le centrali idroelettriche catturano l’energia cinetica dell’acqua, che scorre impetuosa in fiumi e canali, naturali o artificiali. Dalle dighe alle turbine, un percorso complesso e affascinante trasforma la forza dell’acqua in elettricità. L’acqua, convogliata attraverso condotte forzate, fa ruotare le turbine, che a loro volta azionano i generatori elettrici, producendo l’energia che alimenta le nostre case e le nostre industrie. Esistono diverse tipologie di centrali idroelettriche, ognuna adattata al contesto geografico e alle esigenze energetiche: ad acqua fluente, a bacino e ad accumulo, ognuna con le sue peculiarità e i suoi vantaggi.
L’idroelettrico, fonte di energia rinnovabile e pulita, è un elemento chiave nella transizione ecologica. Un’energia affidabile ed economica, che non produce gas serra, ma che può essere influenzata dalla scarsità d’acqua, soprattutto durante i periodi di siccità. L’Italia, con la sua particolare conformazione geografica, è un terreno fertile per lo sfruttamento dell’energia idroelettrica, ma non può dipendere esclusivamente da essa. La diversificazione delle fonti energetiche, con l’integrazione di solare, eolico e geotermico, è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.
Le recenti siccità, con fiumi in secca e bacini svuotati, hanno messo a dura prova il sistema idroelettrico italiano, evidenziando la necessità di una gestione oculata delle risorse idriche e di una strategia energetica diversificata e resiliente. L’acqua, fonte di vita ed energia, richiede rispetto e attenzione, per garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.
Che cosa sono
Le centrali idroelettriche sfruttano l’energia cinetica dell’acqua, proveniente da corsi d’acqua naturali o artificiali, per produrre energia elettrica rinnovabile. Esistono tre tipologie principali di centrali idroelettriche: ad acqua fluente, a bacino e ad accumulazione.
Il funzionamento generale prevede uno sbarramento (diga o traversa) che crea un invaso o bacino idroelettrico. L’acqua, convogliata attraverso opere di adduzione, canali e gallerie di derivazione, viene indirizzata tramite condotte forzate verso le turbine idrauliche. La rotazione delle turbine genera energia meccanica, successivamente convertita in energia elettrica da un generatore elettrico (alternatore) direttamente collegato alla turbina. L’acqua, dopo aver azionato le turbine, viene restituita al corso d’acqua attraverso un canale di scarico.
L’energia elettrica generata viene trasformata per consentirne la trasmissione a lunga distanza. Un trasformatore riduce l’intensità di corrente e aumenta la tensione prima che l’energia venga immessa nelle linee di trasmissione. Giunta a destinazione, l’energia subisce una nuova trasformazione: un altro trasformatore aumenta l’intensità di corrente e riduce la tensione, rendendola adatta all’utilizzo industriale, commerciale e domestico.
Tipologie di centrali idroelettriche
I tre principali tipi di centrali idroelettriche si distinguono per il modo in cui sfruttano l’acqua per generare elettricità:
- Centrali ad acqua fluente:
Queste centrali, situate in prossimità di fiumi con dislivelli modesti, deviano l’acqua attraverso un canale per azionare le turbine collegate agli alternatori, che a loro volta producono energia elettrica.
- Centrali a bacino (o a salto):
Sfruttando il dislivello tra un bacino di carico (lago naturale o artificiale creato da una diga) e il livello a valle, l’acqua viene convogliata attraverso condotte forzate per azionare le turbine. Un bacino di calma a valle riduce la turbolenza dell’acqua prima che venga reimmessa nel fiume. La capacità di accumulo del bacino offre flessibilità nella gestione della produzione energetica, adattandola alla domanda.
- Centrali con impianti ad accumulo:
Simili alle centrali a bacino, dispongono anche di un bacino di raccolta a valle. Ciò consente di pompare l’acqua utilizzata per generare energia durante il giorno dal bacino inferiore a quello superiore, sfruttando l’energia elettrica in eccesso prodotta in momenti di bassa domanda. Questo sistema massimizza l’efficienza e la disponibilità energetica.
Oltre a queste tre tipologie principali, esistono anche centrali che sfruttano l’energia delle maree e delle onde (energia mareomotrice). Sebbene meno diffuse, queste centrali utilizzano sistemi a barriera per generare elettricità dallo spostamento delle masse d’acqua. Diverse forme di energia mareomotrice includono: l’energia delle correnti marine, l’energia cimoelettrica (delle onde), l’energia talassotermica (differenza di temperatura) e l’energia osmotica (differenza di salinità).
L’Idroelettrico come Soluzione per la Transizione Ecologica
L’energia idroelettrica rappresenta un’opzione significativa per la transizione energetica, poiché utilizza una risorsa pulita e rinnovabile: l’acqua. Durante il processo di generazione elettrica, queste centrali non emettono gas serra, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.
Generalmente, le centrali idroelettriche sono considerate affidabili e a costi contenuti, poiché non dipendono da combustibili costosi e possono essere facilmente adattate alle variazioni nella domanda di energia. Tuttavia, durante le stagioni più calde, la produzione di energia idroelettrica può subire interruzioni a causa della scarsità d’acqua, che deve essere riservata anche per usi agricoli e domestici.
Analizzando il contesto locale, si nota che la geografia italiana, con la sua dorsale appenninica e l’arco alpino, presenta pendenze favorevoli che possono aumentare l’efficienza delle centrali idroelettriche.
Tuttavia, l’Italia, come molte altre nazioni, non può fare affidamento esclusivamente sull’idroelettrico per la transizione ecologica. È fondamentale integrare diverse fonti di energia rinnovabile, come l’energia solare, eolica e geotermica, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 e il 2050.
Le gravi siccità degli ultimi anni, con fiumi in secca e bacini artificiali svuotati, hanno messo a dura prova la funzionalità delle centrali idroelettriche in Italia, compromettendo la disponibilità energetica. La diminuzione delle precipitazioni ha portato a un abbassamento drastico dei livelli di fiumi e laghi, nonché a una riduzione del riempimento dei bacini utilizzati per la produzione di energia. Per far fronte alla carenza d’acqua per l’agricoltura nell’estate del 2022, Enel ha dovuto rilasciare 200.000 metri cubi d’acqua al giorno nel fiume Brembo e 250.000 nel fiume Serio, mentre nel bacino del Po è stata necessaria una riduzione del 90% della produzione delle mini centrali idroelettriche lungo i canali di irrigazione.